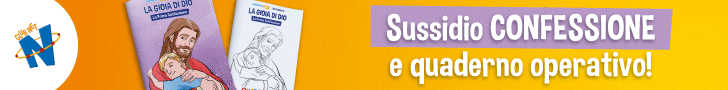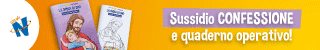TESTO Una Chiesa a dodici porte
don Alberto Brignoli ![]() Amici di Pongo
Amici di Pongo
VI Domenica di Pasqua (Anno C) (05/05/2013)
Vangelo: Gv 14,23-29 ![]()

23Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 28Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 29Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Il libro dell'Apocalisse, la cui lettura ci ha accompagnato durante questo Tempo di Pasqua, non è certo di facile interpretazione, e questo lo sappiamo bene. Forse pure questo è uno dei motivi per cui con una certa difficoltà ne azzardiamo un commento all'interno della nostra predicazione domenicale. A me oggi piace fare riferimento alla seconda lettura per un particolare forse del tutto marginale rispetto al significato del testo, ma che crea una certa suggestione se messo in relazione con il resto della Liturgia della Parola, in particolare con la prima lettura.
Giovanni, nel testo dell'Apocalisse, descrive la visione della Nuova Gerusalemme che "scende dal cielo...risplendente della gloria di Dio". Le simbologie e i significati legati a questa descrizione sono molteplici: ma quello che a me colpisce è il particolare di queste "porte", dodici, tre per ognuno dei quattro punti cardinali della città, quasi a sottolineare l'apertura universale di questa città ad ogni realtà umana. Se è vero (come pare) che la Nuova Gerusalemme celeste è il "tipo", il modello della Comunità dei credenti, ossia della Chiesa, a cui la comunità di Giovanni guarda come a qualcosa cui bisogna tendere, allora questa Chiesa si caratterizza per le sue numerose porte, aperte su ogni lato dell'umanità, su ogni frontiera, su ogni uomo.
Proprio come la Chiesa che esce dal Concilio di Gerusalemme, il primo della storia, di cui ci parla la prima lettura. La situazione - si comprende bene - riflette l'annosa questione del modo di professare la religione cristiana: il cristianesimo è il compimento della legge giudaica oppure ne rappresenta un superamento e quindi una novità, pur derivando da essa? Per essere dei buoni cristiani, bisogna essere innanzitutto (come lo fu Gesù) dei buoni osservanti della legge giudaica oppure si può arrivare alla fede cristiana a prescindere dal passaggio attraverso la religione di Israele? Dal momento che la religione giudaica era un tutt'uno con la sua cultura, il suo territorio, la sua lingua, e dal momento che per essere buoni cristiani occorreva anzitutto essere osservanti della legge giudaica, la conclusione poteva diventare quella per cui al di fuori del territorio e della cultura giudaica non si poteva accedere al cristianesimo: come la mettiamo, allora, con i greci, con gli abitanti della Siria, dell'Asia Minore, dell'area Balcanica, della Turchia e alla fine di Roma che - grazie soprattutto alla predicazione di Paolo e di Barnaba, ma non solo - avevano abbracciato il cristianesimo senza passare attraverso il giudaismo ma provenendo direttamente da quello che allora era considerato "paganesimo"? Se poi a questo aggiungiamo l'aggravante di gente che, per i propri interessi, vuole costringere gli altri a giungere alla salvezza attraverso l'unico cammino possibile, cioè quello che loro stessi avevano fatto (come i Giudei che volevano imporre la legge di Mosè alle comunità di Antiochia), allora l'idea del cristianesimo come religione universale, e della Chiesa come realtà aperta ad ogni uomo, inizia davvero a scricchiolare.
Sono questioni che a noi paiono ormai superate: che uno sia italiano o scandinavo o nordafricano o indiano o sudamericano o australiano, poco conta, perché possa dirsi cristiano. Il messaggio di Cristo è universale, e questo è tranquillamente accettato. Non era così a quei tempi.
Fatte però le debite distinzioni legate alle diversità epocali, dopo duemila anni di cristianesimo non diamo per scontato che la Chiesa oggi abbia ormai acquisito una dimensione piena di universalità. A livello territoriale, lo dicevamo prima, non si discute: ma a livello culturale, teologico e soprattutto sul piano dell'etica e del comportamento cristiano, ci sono ancora parecchie difficoltà ad accettare la "cattolicità", l'universalità del messaggio cristiano come "specifico", "sostanziale" del cristianesimo. Ancora oggi, la Chiesa, pur avendo ben presente il modello della Gerusalemme Celeste a cui deve tendere, fatica a mantenere aperte su ogni punto cardinale quelle "dodici porte" di cui l'Apocalisse ci parla.
Abbiamo ancora troppe chiese che lasciano chiuse le loro porte "ad ogni uomo"; troppe chiese hanno le porte chiuse! E non mi riferisco ai templi, che per ragioni pratiche molte volte sono costretti a chiudere i loro battenti al termine di una funzione liturgica per evitare il trafugamento di opere d'arte. Mi riferisco alle chiese nel senso di "comunità di credenti", che spesso chiudono le loro porte invece di aprirle. Mi riferisco a comunità di credenti che invece di accogliere allontanano la gente. Mi riferisco a comunità di credenti che a parole dicono: "Ci vuole gente nuova"; poi però quando arriva qualcuno di nuovo, con atteggiamenti degni della miglior gelosia impediscono a chi è nuovo di inserirsi in un cammino di fede e di impegno pastorale. Mi riferisco anche a comunità di credenti rette e manipolate da cristiani ben pensanti di prima categoria e di alto profilo culturale che vorrebbero (come i giudei della prima lettura) imporre agli altri un modo di vivere la fede che nemmeno loro sono in grado di portare avanti con coerenza. Mi riferisco a coloro che fanno del cristianesimo una religione dell'aut - aut (o vivi così o non sei cristiano) invece di adottare uno stile dell'et - et (dando spazio e posto a ognuno nella Chiesa, ognuno con le proprie peculiarità e i propri modi di vivere il cristianesimo).
Certamente, su alcune cose di fondo bisogna intendersi, perché la Chiesa non è un concentrato di anarchie. Anche la Chiesa che esce dal Concilio di Gerusalemme ne esce dando come indicazioni alcune "cose necessarie a cui attenersi" e sulle quali è bene che ci sia anche oggi ampia condivisione. Ma se facciamo caso alle "cose necessarie a cui attenersi" indicate nei versetti finali del brano degli Atti degli Apostoli, ci rendiamo conto di come la maggior parte di esse siano legate a situazioni ben precise, determinate da un puntuale contesto storico e culturale, e che vanno continuamente rilette e riadattate alla luce dei tempi che stiamo vivendo.
Se la Chiesa non è capace di rileggere il messaggio cristiano, soprattutto nella sua dimensione sociale ed etica, alla luce dei tempi, delle culture e delle situazioni che si trova a vivere nel prosieguo della storia, rischia di non essere più immagine di quella Gerusalemme del cielo con le dodici porte aperte in ogni direzione. Diventerà sempre più un baluardo inaccessibile, una fortezza inespugnabile, perfetta, inattaccabile, ma - forse - resterà desolatamente vuota.
Il Concilio Vaticano II l'aveva colto già cinquant'anni fa: "É dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna, infatti, conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico". (GS 4).
E ancora: "Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede, infatti, tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane". (GS 11).
Lo Spirito Santo - ce lo ha promesso quest'oggi Gesù - "ci insegnerà ogni cosa".